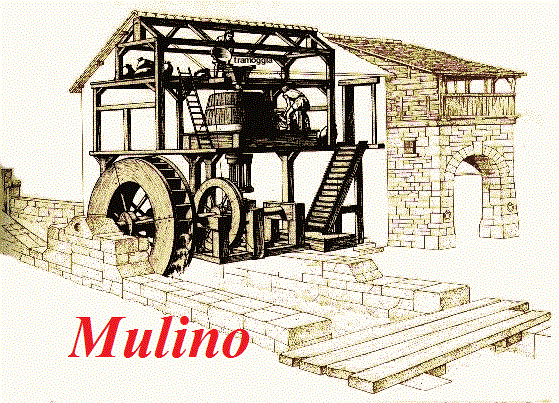In generale il Rinascimento può essere considerato come un periodo in cui si pongono le basi per un’evoluzione tecnologica che coinvolge tutti i campi del sapere scientifico, dalla chimica alla meccanica fino a giungere alla metallurgia. Proprio quest’ultima disciplina determina un’innovazione del mulino, per quanto riguarda alcune delle sue componenti meccaniche; se prima gli ingranaggi, tra cui spicca la ruota dentata-lanterna, erano costituiti in legno, ora, grazie all’introduzione di nuove tecniche di fusione, sono costituiti in ferro. Ne ritroviamo traccia già a partire dai manoscritti degli ingegneri già citati. Un’altra importante innovazione già introdotta precedentemente ma perfezionata in questo periodo di tempo è rappresentata dall’albero a camme, in grado di convertire un moto rotatorio continuo ad un moto rettilineo intermittente.Tra i molti ingegneri che si sono in parte occupati dell’evoluzione tecnica del mulino nel Rinascimento spicca sicuramente Leonardo da Vinci; che all’interno dei suoi manoscritti compie uno studio approfondito sulle ruote dentate; anche se, come già affermato, non ancora in maniera strettamente scientifica. Come lui stesso afferma nel manoscritto Del moto e misura dell’acqua
“Quell' acqua che dà men peso al suo canale, è più veloce.
Quell' acqua ch' è più veloce, più caccia la sua rota.
Quella dà men peso al suo canal, ch' è più diritta.
L' acqua delle molina debbe percotere le pale delle rote in angoli retti.
Quell' acqua che correrà con manco pendente, percoterà la rota più lontano dal perpendiculare della sua caduta.
Quell' acqua che percote più lontano dal perpendicular della sua caduta, dà minor botta.”